«Tomorrow, Tomorrow, and Tomorrow»
«Tomorrow, Tomorrow, and Tomorrow» di Gabrielle Zevin è un romanzo sul lavoro, sui videogiochi, sulla perdita e sull’amore (nel significato ambiguo, anzi, esteso, che «love» ha in inglese).
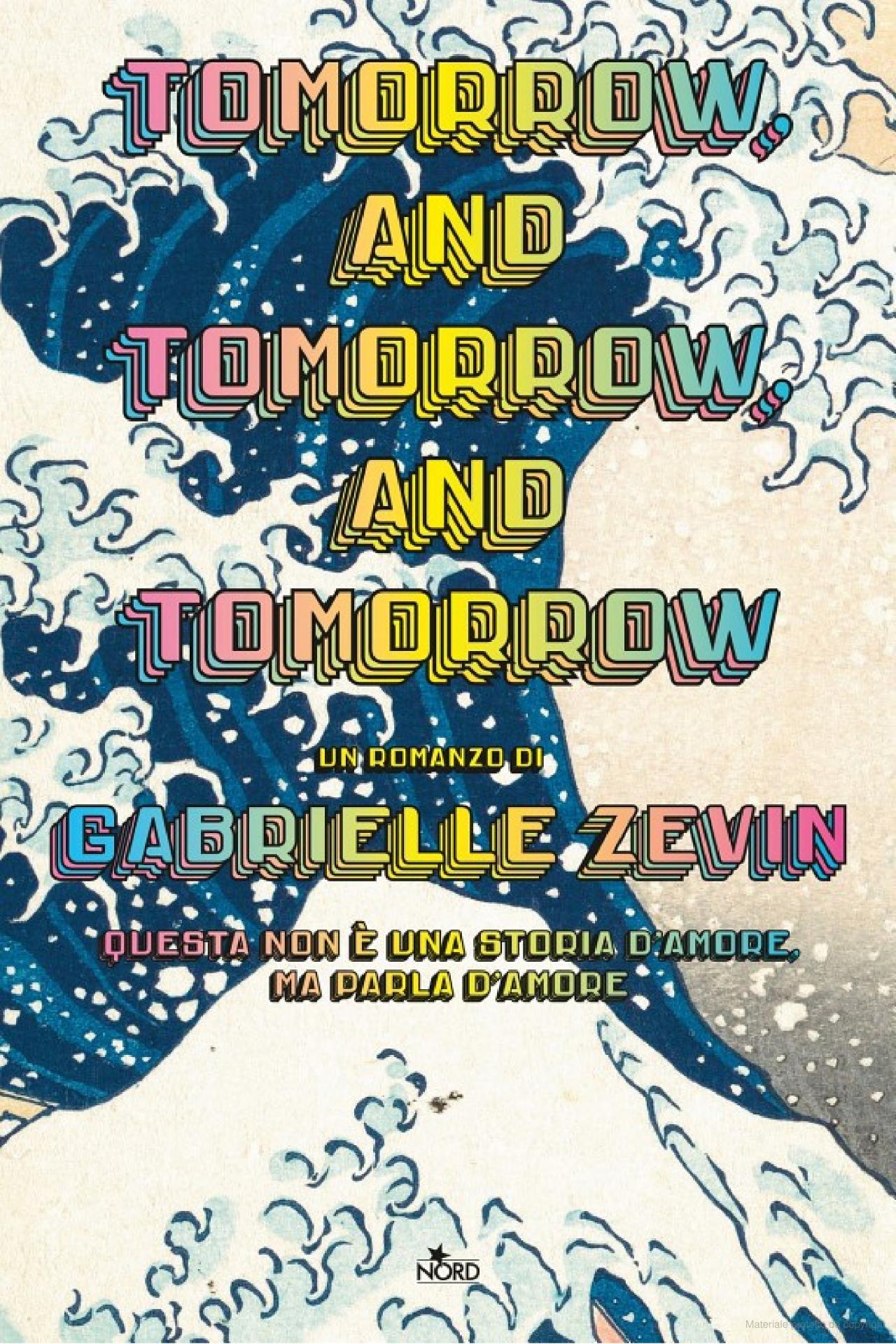
Che sia soprattutto un romanzo sul lavoro lo ha detto l’autrice stessa, un’americana di origini russe, ebraiche e coreane, multicontinentali diremmo, come quasi tutti i personaggi del libro. Il lavoro di cui parla è il lavoro creativo di chi inventa, scrive e sviluppa videogiochi: e chi è del settore si compiacerà di vedere finalmente rappresentato con una certa fedeltà, al di là di qualche aspetto inevitabilmente romanzato, il mestiere di chi fa videogame indipendenti.
I protagonisti sono un uomo, Sam Masur alias Mazer (Costruttore di Labirinti), e una donna, Sadie Green. Sam e Sadie si conoscono da bambini giocando assieme al computer, e da grandi scelgono entrambi una carriera nel settore come autori e sviluppatori. Autori e sviluppatori possono essere due ruoli diversi, ma qui si parla, almeno all’inizio, di indie in senso stretto, dove capita che i ruoli coincidano. Ma protagonista è anche una terza persona, Marx Watanabe (si chiama così, Marx di nome), che i videogiochi non li sa programmare né inventare, ma diventa il loro produttore, e molte altre cose. Sto sul vago perché è uno di quei romanzi dove la trama è giusto farsela raccontare dal libro, e c’è una bella miscela di successi e fallimenti che rendono ogni spoiler devastante.
In effetti Zevin sembra bravissima a raccontare i fallimenti, così brava e così simile alla vita che non sai cosa aspettarti. Nelle storie di fiction spesso vedi il tocco dell’architetto della narrazione: se è una storia rassicurante, sai che andrà tutto bene, al massimo se è d’azione (e le storie d’azione sono quasi sempre rassicuranti, specie al cinema) ci sarà qualcuno che dovrà sacrificarsi all’ultimo per far vincere il bene; se è una storia triste o cupa, ci sarà una serie di sfighe e quel che potrà andare male andrà tragicamente. Questo libro non è così. Ogni relazione d’amore non sai se durerà: si lasceranno? e si lasceranno bene o male? Non sai neppure se esisterà una relazione: si metteranno mai insieme? Ogni videogioco non sai se avrà successo: piacerà? venderà? piacerà ma non venderà? venderà ma non piacerà? e come la prenderà chi l’ha fatto? Ogni amicizia della storia ha la stessa fragilità, anzi, la fragilità dell’amicizia è un altro dei suoi grandi temi. E anche ogni corpo vivente nella storia è fragile: il cancro guarirà? la disabilità passerà? i problemi sessuali saranno risolti? qualcuno avrà un incidente?
Qua naturalmente entra la metafora, già sentita tante volte ma anche giustamente perché è potente per parlare del medium videoludico, delle vite infinite; nei videogiochi quasi sempre si può rinascere, si può “spawnare” da qualche altra parte dopo la morte. Gli errori si correggono riprovandoci. Il libro parla benissimo delle perdite, inclusi i lutti, come qualcosa che invece non funziona proprio così, ma neanche al contrario di così. C’è un passaggio toccante dove si dice che quando muore qualcuno i superstiti si portano dentro una specie di versione semplificata del morto, algoritmica dico io, costruita sui loro ricordi della persona scomparsa. Cosa direbbe il morto se fosse ancora qui? Chi l’ha conosciuto bene può provare a immaginarselo; ma ovviamente il fantasma in scatola dei sopravvissuti non ha la complessità, la profondità e la capacità di creare pensieri nuovi di una mente intera, viva; è solo una manciata di sinapsi messe a simulare un intero cervello irrimediabilmente scomparso; e del resto anche una mente senza corpo, che vive solo guardando gli altri vivere, non sarebbe come la persona originaria. E poi, dice il libro, pian piano questo fantasma va scemando, diventa sempre più difficile ricordare i dettagli fisici e intellettuali della persona assente. Molto diverso dal respawning. E anche diverso da come un attore prova mille volte una scena in cui il suo personaggio muore, come avviene in una scena gustosa della storia (Zevin sa, e spiega, che teatro e videogame sono parenti).
Sto leggendo un altro romanzo, precedente, di Gabrielle Zevin (La misura della felicità, una resa direi orrenda dell’intraducibile titolo originale The Storied Life of A. J. Fikry), e mi pare che parlare di come si affrontano le perdite e le sconfitte sia qualcosa in cui eccelle. Quando arriva la botta, è devastante, è una bomba atomica che lascia un cratere in cui si sprofonda; e ognuno sprofonda a modo suo. Come chi legge si augura a ogni pagina, qualcosa succede, con pazienza, e il lutto, in senso stretto o in senso lato, viene elaborato, ma mai messo da parte; non è superato a chiacchiere, ma con la prassi. Succede qualcosa, o qualcuno.
Da come sto parlandone sembra che ci sia molto sentimentalismo. E qui vorrei dire: no, c’è sentimento ma non sentimentalismo. In verità però c’è proprio il sentimentalismo: cerca di farti piangere di commozione in continuazione e, almeno con me, ci riesce; ma è un sentimentalismo concreto, pratico. Ti puoi commuovere per quel che succede nella scrittura del codice di un videogioco o al piede di un personaggio o per un oggetto lasciato su una scrivania. La materia conta.
E contano davvero i videogame, che non sono un pretesto narrativo arbitrario, tipo «Be’, i protagonisti dovevano pure avere una qualche passione e un qualche mestiere, e allora facciamo che fanno giochi per il computer, ma potevamo anche fare che erano giornalisti di cronaca rosa e più o meno funzionava lo stesso…». No. Questo libro parla davvero di gente che fa videogiochi, non è un’allegoria di qualcos’altro o un elemento di colore. C’è il furore creativo di chi vuole fare un gioco “profondo”, coi primi tentativi del gioco a chiave, con un messaggio provocatorio, e poi del gioco d’autore, con una storia e un’estetica uniche. Si parla anche di un giochino fatto per compito a lezione di game development, Emily Blaster, una specie di arcade poetico basato sulle poesie di Emily Dickinson; e nel mondo reale Dan Vecchitto è stato incaricato dalla casa editrice di farlo davvero, e lo si trova linkato dal sito dell’autrice. Quando la carriera dei protagonisti inizia a maturare, ci sono i posizionamenti commerciali, i dilemmi nelle scelte societarie, la tensione continua tra fare quello che si vorrebbe e fare quello che è logico fare nel mercato. Ci sono le discussioni tese sulle partnership, su dove stabilire un ufficio, sul titolo definitivo da dare a un gioco quasi pronto (pagine geniali quelle dove si inizia dalla proposta di chiamarlo Love Doppelgängers…). C’è il rapporto con i media. Ci sono i sequel, le autocitazioni, le comunità più o meno tossiche di giocatori, e la tecnologia che avanza, da quando ci si faceva i motori grafici in proprio ai multiplayer online. Credo che il libro riesca nell’impresa quasi impossibile di parlare di questo mondo in un modo che funziona sia per gli intenditori sia per i profani; e per i pignoli, in appendice spiega le licenze che l’autrice si è presa, dimostrando una competenza a prova di gatekeeper.
C’è anche la politica, un po’. Io ne avrei voluta di più ma sapete come sono; Zevin è una liberal: mi accontento del personaggio chiamato Marx. C’è la politica dentro i videogiochi, che via via parlano di fascismo, di immigrazione e identità culturali miste, e di diritti sessuali; un videogioco dove ci si può sposare tra personaggi dello stesso sesso entra nel dibattito politico e questo crea una serie di conseguenze importanti (la storia non è ambientata ai giorni nostri, ma un po’ prima, quando ancora poteva fare scandalo).
Credo che questo libro diventerà il romanzo su chi fa giochi digitali. Stupisce che ci sia voluto così tanto perché ne uscisse uno, ma probabilmente servivano alcune rivoluzioni che sono avvenute nel settore. D’ora in poi avrà l’autorità di un classico, quindi leggetevelo se siete del ramo, e se non siete del ramo leggetevelo lo stesso e forse vorrete essere del ramo, come quando si legge Agatha Christie e per un po’ si spera di assistere presto a un omicidio in una villa.